Siamo diventati superficiali? La colpa è (anche) di internet
Cosa ho imparato leggendo “The Shallows” di Nicholas Carr
Intendiamoci subito: internet è (stata) un’innovazione fantastica. Ma come accade per molte innovazioni, mentre siamo stati distratti nell’apprezzare quanto sia diventato facile avere a disposizione qualsiasi tipo di contenuto (come video divertentissimi di gente che cade o immagini di cuccioli che fanno cose coccolose da cuccioli), abbiamo sottovalutato (per non dire completamente ignorato) qualche piccola conseguenza.
The Shallows: What the Internet is Doing to Our Brains è un saggio scritto e pubblicato da Nicholas G. Carr (per W. W. Norton & Company) nel 2010 che riflette sulle conseguenze che Internet ha avuto per il cervello umano. Un paio di anni prima, nel 2008, l’aveva messa giù in termini meno delicati, scrivendo un articolo su The Atlantic intitolato Is Google Making Us Stupid?
Se quindi è capitato anche a te di sentirti più stupidə, superficiale o (molto più probabilmente) avere l’impressione che quasi tutti coloro che ti circondano lo siano sempre di più (di solito è più facile), sappi che potrebbe esserci una spiegazione scientifica. In particolare, ci sono tre punti principali interessanti su cui la lettura di The Shallows mi ha fatto riflettere:
Il cervello umano non è statico: si adatta in continuazione sulla base degli stimoli, delle condizioni e dei traumi;
Internet è in buona compagnia: le conseguenze (quasi mai previste) delle innovazioni sono una costante delle grandi rivoluzioni della storia umana (le mappe, l’orologio, la scrittura, la stampa a caratteri mobili);
La scienza sembra confermare che Internet ha significativi effetti collaterali (che riguardano soprattutto la memoria).
La straordinaria flessibilità del cervello: nel bene e nel male
Per molti anni abbiamo pensato che il cervello umano evolvesse e si formasse nei primi anni di vita di una persona, per poi diventare «stabile» una volta raggiunta l’età adulta (e poi decadere nel corso della vecchiaia). In realtà, si è scoperto in tempi più recenti la cosiddetta neuroplasticità, ossia la capacità del cervello di cambiare e «riorganizzarsi» sulla base delle esperienze, degli stimoli esterni, delle circostanze.
È innanzitutto un’ottima notizia! Perché questo significa che le persone che perdono l’utilizzo di uno dei sensi (come la vista o l’udito) hanno la possibilità di migliorare e ampliare gli altri sensi, grazie alla capacità del cervello di «occupare» le zone che prima erano dedicate a quelle attività per, andando a compensare eventuali danni cerebrali.
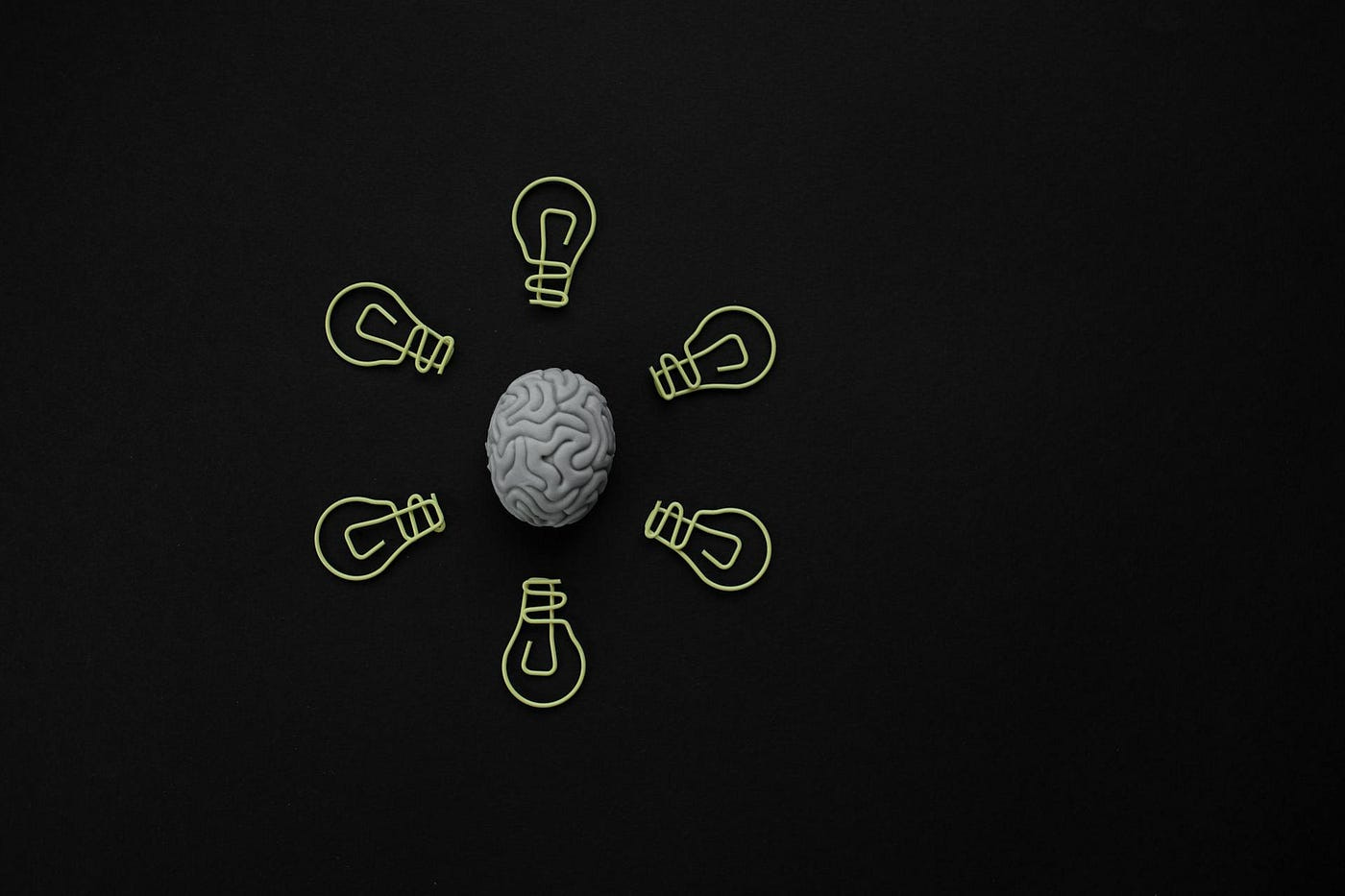
La notizia meno buona è che plasticità non significa elasticità. Il cervello infatti, una volta sviluppata una nuova attività cerebrale, tende a ripeterla per rafforzarla e renderla un’abitudine. Le routine, infatti, ci aiutano a utilizzare questa parte del nostro corpo in maniera sempre più efficiente (utilizzando meno energie), ma rendendoci allo stesso tempo “intrappolati” nei comportamenti rigidi che ne derivano.
È quindi possibile che l’uso di un computer o di uno smartphone connessi a Internet modifichi il nostro cervello? La risposta a questa domanda non riguarda tanto i singoli individui, ma la nostra specie nel suo complesso.
Le innovazioni: qualcuno pensi alle conseguenze!
Molte innovazioni nella storia hanno fortemente riconfigurato i paradigmi attraverso cui interpretiamo la realtà. L’introduzione e diffusione su larga scala di nuovi strumenti (come sono stati, ad esempio, le mappe e gli orologi) hanno completamente cambiato il modo di considerare lo spazio e il tempo. E la stessa cosa vale per gli strumenti intellettuali, categoria nella quale rientrano le tecnologie digitali che stanno influenzando la nostra contemporaneità.
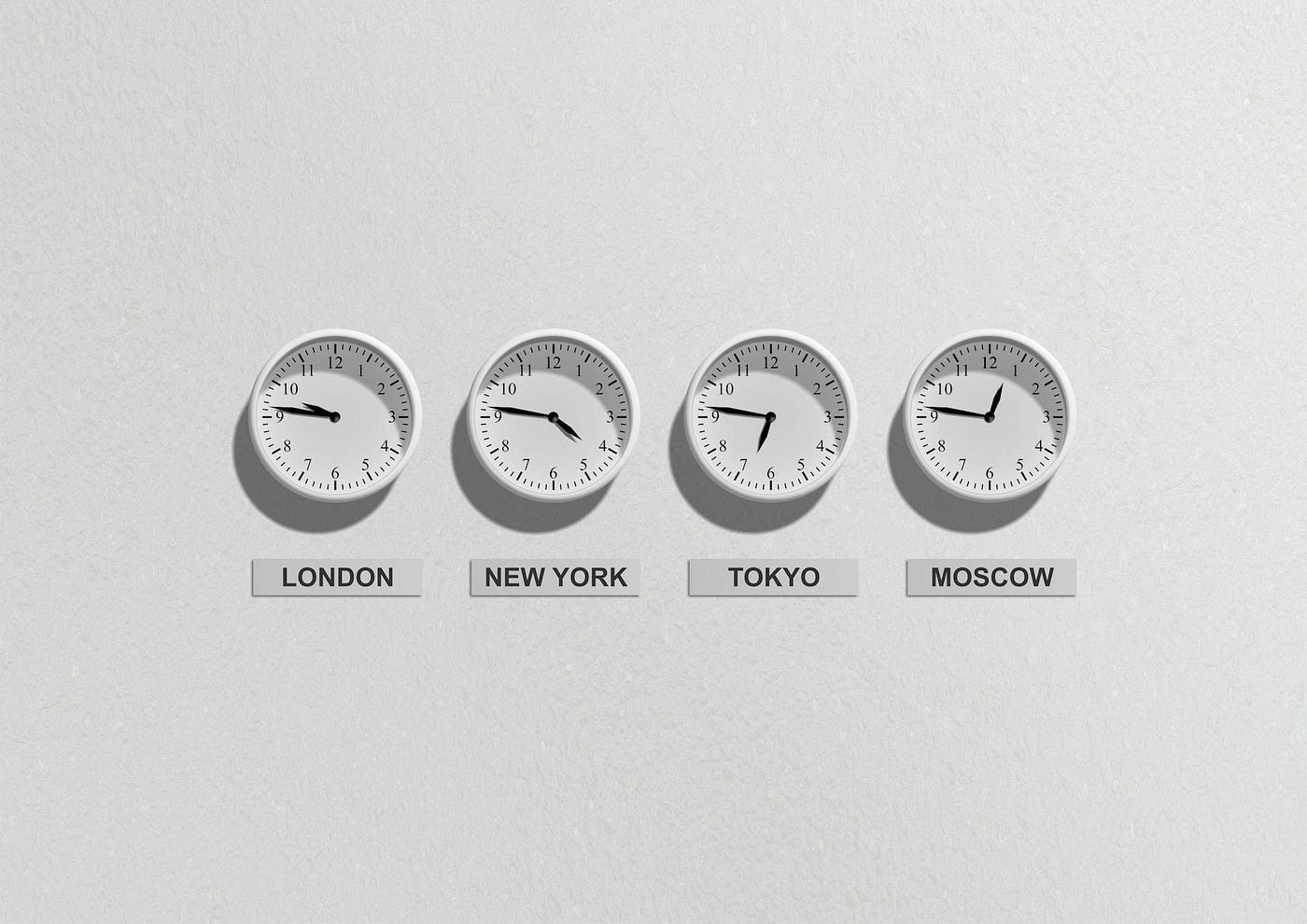
Un aspetto interessante sottolineato da Carr è che gli inventori raramente considerano l’etica intellettuale di una nuova tecnologia o di un nuovo strumento. Spesso, queste invenzioni nascono per rispondere a problemi specifici, dilemmi scientifici o ingegneristici, senza che le persone considerino le più ampie implicazioni del loro lavoro.
Le conseguenze dell’adozione su larga scala dell’orologio meccanico non erano ocerto nelle intenzioni di coloro che hanno lavorato a concepire e realizzare l’oggetto. Ma a seguito della sua invenzione (e successiva miniaturizzazione che ha portato l’orologio a essere nelle tasche e sui polsi di chiunque), il mondo ha cambiato completamente il modo di regolarsi e rapportarsi, mentre gli individui si sono trovati accanto a sé uno strumento in grado di ricordare costantemente il tempo trascorso, quello impiegato in attività utili, quello perso, quello buttato via. Fornendo così un nuovo modo di guardare ai propri successi e alla propria produttività e dando, secondo alcuni, un forte e decisivo impulso verso l’individualismo come tratto saliente del mondo sviluppato che conosciamo oggi. Tutti questi sono stati “effetti collaterali” della nuova tecnologia, ma sono proprio gli effetti collaterali e le implicazioni intellettuali ed etiche delle invenzioni che hanno un effetto più profondo su tutti noi.
A volte questi effetti sono per di più positivi: si pensi all’invenzione della scrittura prima e della stampa a caratteri mobili poi. Sono stati due momenti nella storia dell’umanità che hanno cambiato profondamente e in meglio il modo di vivere, di imparare e di leggere.
E Internet? L’invenzione e la diffusione di Internet hanno tutte le carte in regola per rientrare in questa categoria, nel bene e nel male.
Gli effetti di Internet sui nostri cervelli
InThe Shallows (la cui traduzione letterale, non a caso, è «I superficiali») vengono raccontati alcuni esperimenti fatti proprio per dimostrare quanto uno dei lati positivi di Internet possa diventare un pericolo per la nostra capacità di apprendere. In particolare, i riflettori sono puntati sulla natura multimediale dell’esperienza sul web, che sembra limitare piuttosto che aumentare la capacità di acquisire informazioni.

Da questo punto di vista è emblematico l’esperimento fatto da alcuni ricercatori che hanno diviso una classe di studenti in due gruppi: al primo gruppo è stato consentito di navigare liberamente su Internet mentre seguiva la lezione (registrando al contempo il tipo di attività svolte su internet e la tipologia di siti visitati), mentre al secondo gruppo, che ha assistito alla stessa identica lezione, è stato impedito di accendere i propri computer (all’epoca dell’esperimento, gli smartphone non venivano considerati). Subito dopo la lezione, entrambe i gruppi sono stati sottoposti a un test con l’obiettivo di capire quanto ricordassero della lezione appena terminata: il gruppo di studenti a cui era stato permesso di navigare liberamente online ha avuto risultati significativamente peggiori rispetto al secondo gruppo. E ben poca differenza esisteva tra coloro che ne avevano approfittato per cercare contenuti collegati ai temi della lezione e chi, invece, aveva deciso di controllare le email o guardare video che non c’entravano nulla.
Non è l’unico esperimento che è stato condotto e che viene raccontato nel libro: ce ne sono molti quindi che sostengono la tesi per cui Internet stia modificando il funzionamento dei nostri cervelli. Il meccanismo principale su cui sembra influire è quello della formazione della memoria, in particolare quella di lungo termine. Questo tipo di memoria si genera nel momento in cui dedichiamo attenzione alle idee che immagazziniamo e ci torniamo su per approfondirle, identificando collegamenti con nozioni e informazioni che abbiamo appreso. Questa attività fondamentale rischia di essere fortemente depotenziata dall’esistenza del web: avere tutto a disposizione pressoché ovunque e in qualsiasi momento incentiva ben poco le persone a compiere questa azione di ripercorrere e cristallizzare nelle menti le idee e i concetti importanti. “Tanto sono tutte a portata di click o tap”. Che è fantastico, se pensiamo alle infinite possibilità di accesso ai dati e alle informazioni che abbiamo su larga scala. Ma, al tempo stesso, è preoccupante per gli effetti (non previsti) che ne possono derivare.
Quindi Internet è il male?
Internet non è il male, anzi. Il pericolo è quello di non aver sufficiente consapevolezza di come da nostro alleato possa diventare anche un’arma che ci indebolisce.
La lettura di questo libro mi ha quindi ricordato che, sebbene sia faticoso avendo a disposizione uno strumento così potente come il web, bisogna sforzarsi di non essere superficiali. Perché come ricordava Seneca duemila anni fa:
«essere ovunque è come non essere da nessuna parte».
E io spero di non essere stato troppo superficiale nel riassumere quello che ho imparato da questo testo.
Se ti interessa acquistare e leggere questo libro, puoi farlo qui (link affiliato).
Gli approfondimenti del mese di Signor Ponza™️ è uno spinoff della newsletter I libri del mese di Signor Ponza.




