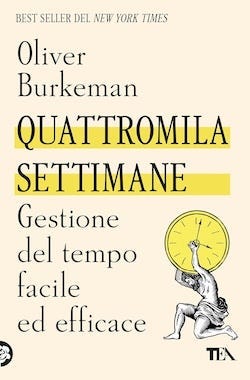Come usare al meglio il tempo a disposizione e vivere serenamente i limiti dell’esistenza umana
Il time management in chiave filosofica di Oliver Burkeman
Non vale prendere in mano la calcolatrice e ovviamente non vale nemmeno cercare su internet. Se ti dovessi chiedere a bruciapelo quante sono le settimane a disposizione (in media) di un essere umano, che cosa risponderesti?
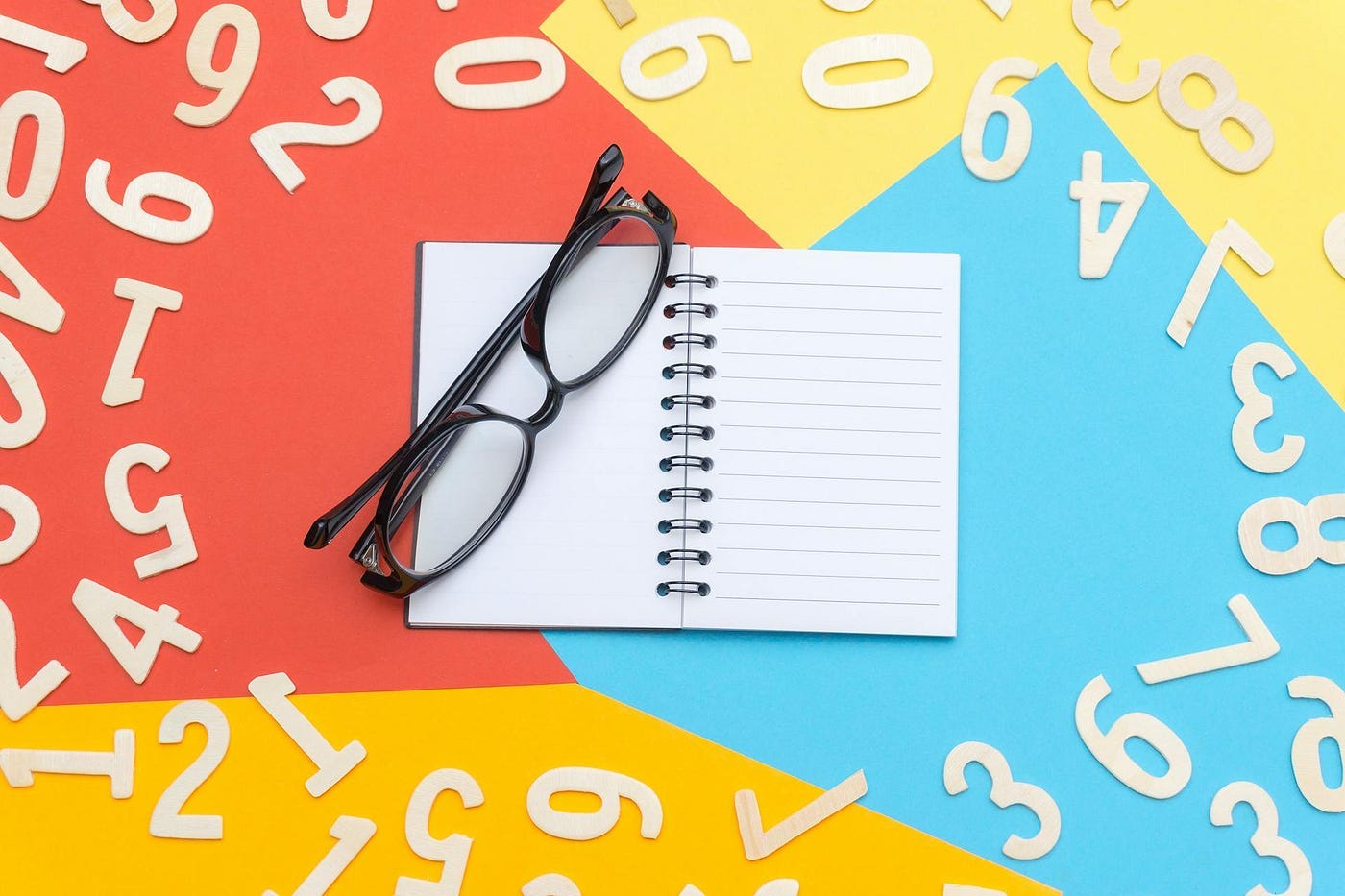
La risposta corretta è circa 4000 settimane. Non è un numero piccolo se consideriamo che si tratta di quattro volte mille (!), ma è pochissimo se si pensa che è tutto il tempo che abbiamo a disposizione su questo pianeta e che, almeno una parte, per molti di noi è già trascorsa.
Non è un caso quindi che il titolo originale del saggio che ha scritto Oliver Burkman sia Four Thousand Weeks: Time Management for Mortals (in italiano è stato tradotto come Quattromila settimane: gestione del tempo facile ed efficace, edito da TEA). È un testo che, a discapito del sottotitolo, non si occupa davvero di time management. O meglio, lo fa, ma in modo diverso dalla maggior parte degli altri contributi sul tema che ho letto: non gli ennesimi strumenti e nuove tecniche per gestire in modo ottimale il proprio tempo. Piuttosto, una filosofia che aiuti a considerare il tempo a disposizione in modo “sano”, tenendo conto di quanto questo sia limitato e di quanto siamo limitati noi come esseri umani.
Dopo aver completato la sua lettura, ci sono cinque aspetti che mi hanno colpito, fatto riflettere a lungo e che vorrei approfondire di seguito. In particolare:
Il progresso tecnologico e l’aumento del benessere avrebbero dovuto portarci in una direzione diversa (e migliore): siamo sicuri che stiamo vivendo le nostre vite al meglio?
Accettare i limiti dell’esperienza umana è la più importante azione di time management che si possa fare.
La chiave per vivere al meglio il proprio tempo è decidere, non controllare.
Chi considera l’attenzione come una risorsa sbaglia di grosso (l’attenzione è molto più che una risorsa).
10 suggerimenti per abbracciare la filosofia di Burkenam e provare a vivere al meglio le nostre 4000 settimane.
Keynes ci aveva visto male
Keynes aveva predetto un mondo che, purtroppo, non è esattamente quello che stiamo vivendo (metto le mani avanti: sto per operare una grande semplificazione del suo pensiero). Sosteneva infatti che, grazie all’evoluzione delle tecnologie e all’aumento del benessere, gli esseri umani avrebbero avuto a disposizione una marea di tempo libero perché ormai sollevati dall’obbligo del lavoro (automatizzato e svolto in gran parte dalle macchine) e dalle preoccupazioni economiche (guadagnando più di quanto ci servisse). La vera sfida, diceva, sarebbe stata come occupare le giornate e come utilizzare una ritrovata libertà.
Si sbagliava alla grande: oggi, se e quando guadagniamo soldi a sufficienza per rispondere a buona parte dei nostri bisogni, semplicemente ce ne creiamo di nuovi, aspirando a stili di vita più elevati. La conseguenza è che ciascuno di noi è spinto a lavorare sempre di più per guadagnare ancora di più per soddisfare nuove esigenze. Non a caso, siamo arrivati a considerare l’essere indaffarati a tutte le ore del giorno e della notte come un simbolo di prestigio.
Dall’idea che essere ricchi possa signifcare non lavorare, sembra che ci stiamo muovendo in direzione opposta, con impatti anche su chi ricco non è affatto: chi è al vertice, per cercare di guadagnare ancor più soldi, cerca tipicamente di tagliare i costi e migliorare l’efficienza, scaricando questa pressione su chi è più in basso nella scala gerarchica, costringendo altre persone a loro volta a lavorare di più. Si innesca così un circolo vizioso da cui è difficile uscire e che ha come risultato una grande frustrazione e insoddisfazione generale.
L’unica cosa che conta nel time management: accettare i limiti
Chi frequenta la letteratura sulla produttività e lo sviluppo personale (come lo scrivente) sa che potenzialmente esistono infiniti strumenti, approcci, teorie che hanno tutti un obiettivo comune, più o meno esplicitamente dichiarato: spiegare come riuscire a fare sempre di più nel corso delle nostre giornate.

Ma è proprio in questa idea che l’approccio del “fare sempre di più” mostra le sue crepe: più ci si impegna e si riesce a gestire in maniera ottimale il proprio tempo, più aumenta l’illusione di poter raggiungere il controllo totale, più la vita diventa stressata, vuota e frustrante. Come se non bastasse, più si diventa efficienti, più si diventa anche i destinatari delle crescenti aspettative e richieste da parte degli altri (colleghi, familiari, amici). Insomma, una fregatura su tutta la linea.
Il rimedio? Imparare a fare i conti con il concetto di finitezza e accettare i limiti che l’essere umano ha. Se si accettano i propri limiti e si rinuncia al tentativo disperato di aumentare la propria capacità di portare a termine più compiti, allora si potrà condurre una vita produttiva, piena di significato e di gioia.
Un altro aspetto importante con cui confrontarsi è che l’illusione di avere controllo sul futuro (altro esempio cristallino di come ci rifiutiamo di accettare i limiti dell’esperienza umana). Il futuro non può essere predetto e non c’è modo di essere certi di che cosa accadrà domani.
Giustamente postresti pensare: e quindi che senso ha pianificare? Pianificare è comunque essenziale perché è un’attività grazie alla quale costruiamo una vita che abbia significati (e ci consente di esercitare le nostre responsabilità verso altre persone, prendendo impegni). Ma non bisogna cadere nell’errore di pensare alla pianificazione come uno stumento attraverso il quale catturiamo il futuro: i nostri piani sono solo un pensiero. Sono formulazioni di intenti che facciamo nel presente, una dichiarazione di come idealmente vorremmo influenzare il futuro. Ma il futuro non è in alcun modo vincolato ad obbedire ai nostri intenti ed è importante averlo a mente sempre.
Da controllare a decidere: tre principi per liberarsi delle cose poco importanti
Il verbo “decidere” deriva dal latino e significa “tagliare via”. Ecco perché è importante tornare alla radice del suo significato: siccome il futuro non è prevedibile (e non possiamo esercitare il controllo su quello che accadrà), piuttosto è importante focalizzarsi sul presente e indirizzare le nostre energie e le nostre attenzioni verso ciò che è veramente importante, tagliando via ciò che è superfluo.

In supporto a questa filosofia, Burkenam elenca tre principi di quella che definisce “l’arte della negligenza creativa”:
Quando si tratta di allocare il tempo, metti te stesso al primo posto: se non ritagli del tempo per te stesso oggi, non illuderti che ci sarà nel futuro un momento in cui avrai magicamente eliminato tutte le tue todo list e avrai a disposizione tonnellate di tempo libero. Un esempio: dedica la prima ora della tua giornata a lavorare al progetto più importante per te e fissa in calendario dei momenti per te stesso (meetings with yourself).
Limita i progetti da portare avanti: scegli un numero contenuto di progetti che segui contemporaneamente, sia dal punto di vista lavorativo (dove possibile), sia per quanto riguarda la tua vita privata.
Resisti al fascino delle priorità secondarie: prova a selezionare le attività e i progetti più importanti e focalizzati solo su quelli. Il resto non merita il tuo tempo.
L’attenzione è la vita, la pazienza è il potere
C’è un errore che spesso viene fatto: considerare l’attenzione come una risorsa. Le risorse sono elementi di varia natura (come cibo, denaro, elettricità, ecc…) che ci facilitano la vita e senza i quali, in alcuni casi, non riusciamo a sopravvivere. L’attenzione — secondo l’autore di Four Thousand Weeks — è invece la vita stessa: l’esperienza di essere vivi consiste nella sommatoria delle cose a cui prestiamo attenzione. Alla fine della nostra vita, quando ci guardiamo indietro, la nostra esistenza sarà stata, momento per momento, quello a cui abbiamo attribuito la nostra attenzione. Le distrazioni non sono quindi la causa dell’essere distratti: sono i luoghi dove ci rifugiamo per trovare sollievo dal confrontarci con la limitatezza dell’esperienza umana.

Accanto all’attenzione, nel mondo contemporaneo la pazienza sta diventando sempre di più una forma di potere. In contesti caratterizzati dalla fretta e dall’urgenza, la capacità di resistervi diventa un modo per essere avvantaggiati rispetto a tutti gli altri: dedicarsi alle attività che sono importanti per noi, attribuire il giusto tempo, trarvi soddisfazione invece di delegare tutto al futuro è ciò che può fare la differenza.
Coltivare la pazienza significa sviluppare il gusto e l’apprezzamento per l’avere problemi: non ci sarà mai un momento della vita senza problemi. E soprattutto una vita priva di problemi sarebbe assolutamente senza senso: monotona e priva di significati. Un problema è qualcosa a cui dedicare attenzione (quindi, di nuovo, vita).
Inoltre avere pazienza vuol dire saper abbracciare l’incrementalismo radicale: abituarsi a piccoli passi avanti, quelli che consentono di avvicinarsi con costanza ai propri obiettivi. A volte perseguire nella strada intrapresa, anche se inizialmente può sembrare senza risultati.
Un decalogo per abbracciare i limiti dell’esperienza umana
Sebbene il saggio si configuri principalmente come “filosofico”, la chiusura prova a portare un po’ di concretezza ai ragionamenti esposti. L’autore, infatti, propone un decalogo per gestire al meglio le quattromila settimane e dotarsi pur sempre di un approccio strutturato.

Avere due liste di cose da fare: una contenente obiettivi e progetti prioritari — pochi e importanti — e un’altra aperta e potenzialmente infinita da cui pescare, ma solo quando si libera uno spazio per aver completato un progetto della prima.
Focalizzarsi su un grande progetto alla volta: darsi la regola che bisogna prima completarlo e solo dopo si può passare ad altro.
Decidere in anticipo in che cosa si vuole fallire: per rimuovere la vergogna del fallimento (di questo ne ho parlato in un altro articolo), è importante decidere e realizzare ex-ante quali sono i progetti che non porteremo a termine.
Focalizzarsi e celebrare quanto già fatto (e non solo quello che bisogna ancora fare o completare): per farlo, è importante tenere anche una lista di tutti gli obiettivi raggiunti e dei todo completati.
Decidere su cosa investire, anche in termini di impegno personale: in un mondo di social media dove le cose di cui preoccuparsi sembrano infinite, è importante scegliere quali battaglie combattere di attivismo, politica e beneficenza. Non è umanamente possibile essere in prima linea su tutti i fronti: dove non possiamo arrivare noi, può arrivare (meglio) qualcun altro.
Abbracciare la tecnologia “noiosa” e che si pone un singolo obiettivo: il Kindle per leggere è un ottimo esempio, perché è un dispositivo tecnologico, ma consente quasi solamente di svolgere un compito, cioè leggere ebook (eliminando le altre distrazioni).
Ricercare le novità nel mondano: prestando più attenzione alla quotidianità e ai piccoli cambiamenti intorno a ciascuno di noi, si riduce il bisogno costante di cambiamenti o avventure radicali.
Cercare di essere un “ricercatore” anche nelle relazioni: significa adotta un’attitudine alla curiosità in tutti i rapporti che abbiamo con altre persone, ricercando anche in questo caso le piccole novità e i cambiamenti che stimolano il nostro interesse.
Coltivare la generosità istantanea: abbracciare cioè l’impulso di ringraziare e fare gesti, come i regali, sulla base della spontaneità del momento.
Praticare il far niente.
Da persona piuttosto appassionata di strumenti di produttività, confesso che ho iniziato la lettura di Quattromile settimane con un po’ di scetticismo. Ho alzato il sopracciglio varie volte, ma a distanza di settimane mi rendo conto che questo libro ha lasciato dentro di me numerosi spunti di riflessione che mi stanno portando a riconsiderare il modo in cui uso calendari, todo list e applicazioni varie. Di cui ovviamente non mi libererò e delle quali continuerò a scrivere (sebbene con una consapevolezza diversa).
Se ti interessa acquistare e leggere Quattromila settimane di Oliver Burkenam, puoi farlo qui (link affiliato)
Gli approfondimenti del mese di Signor Ponza™️ è uno spinoff della newsletter I libri del mese di Signor Ponza.