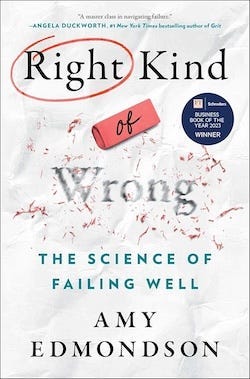Come sbagliare nel modo giusto
Leggere i propri errori nel modo corretto e apprendere dai fallimenti
“Sbagli il 100% dei tiri che non provi a fare”
È una frase celebre di un’altrettanto celebre star dello sport, l’ex giocatore di hockey Wayne Gretzky. Può sembrare una banalità, ma è il nostro rapporto complicato con gli errori, gli sbagli e il fallimento che ci impedisce spesso di compiere passi in avanti, anche se apparentemente semplici.
Lo sbaglio viene spesso automaticamente associato all’aver fallito irrimediabilmente, ma in molti casi non è così, anzi. Gli errori, nel corso della nostra storia e delle nostre storie personali, sono stati sempre indispensabili per progredire, crescere e migliorare.
Come fare quindi a distinguere errori positivi ed errori negativi? Ci prova a spiegarlo Amy Edmondson nel saggio Right Kind of Wrong. The Science of Failing Well (che io ho letto nell’edizione hardcover di Atria Books).
Perché è così difficile accettare di sbagliare?
Sono tre le ragioni principali per cui ci sentiamo a disagio nel momento in cui si fanno errori. La prima è l’avversione legata alla risposta emotiva negativa (fisiologica e istintiva) che si ha come conseguenza di uno sbaglio; la seconda è legata invece allo stigma sociale che viene associato al fallimento; la terza è la confusione che sorge in assenza delle giuste chiavi di lettura che ci permettono di distinguere tra errori “giusti”, come li definisce Edmondson, e “sbagliati”.

Come si caratterizza il “giusto tipo di sbaglio”?
Un errore viene considerato “intelligente” quando presenta alcune caratteristiche:
Prevede che ci pensi accuratamente: in altri termini, significa che prima di compiere l’azione che può portare all’errore ci si è impegnati a valutare il contesto, le conseguenze e la possibilità stessa di esito negativo.
Non provoca danni non necessari: implica cioè la consapevolezza che, per quanto prevedibile, l’eventuale errore commesso non andrà a nuocere verso altri (o altre cose) più di quanto sia inevitabile.
Produce insegnamenti utili per far progredire le conoscenze: vuol dire che pur sbagliando c’è la possibilità di apprendere dall’errore fatto.
Un fallimento intelligente è quello che tipicamente si svolge in un territorio nuovo, in un contesto che presenta una credibile opportunità di avanzare verso un obiettivo desiderato. È informato dalle conoscenze disponibili (ed è quindi guidato dalle ipotesi che vengono fatte in proposito) ed è fatto con l’idea di limitare al minimo le conseguenze negative.
Imparare dai propri errori: una mini-guida
L’apprendimento che segue un “fallimento” è ciò che fa davvero la differenza. Sarebbe bellissimo che fosse tutto automatico, ma non è così.
A volte non ci si rende nemmeno conto di aver fallito, quindi il problema è a monte. Altre volte, cerchiamo di mascherare i fallimenti perché minacciano la nostra autostima o addirittura evitiamo di parlarne o anche solo semplicemente di pensarci. Infine, può anche accadere che non siamo in grado di vedere gli elementi di valore che sono contenuti in un fallimento.

Ecco perché serve innanzitutto un’analisi approfondita dei fattori che hanno portato al risultato negativo (e non un semplice “non ha funzionato, proverò qualcosa di diverso la prossima volta”) e l’abbandono delle analisi che auto-assolvono (“la colpa è di qualcun altro” o “non dipende da me”).
L’obiettivo finale dovrebbe essere quello di coltivare un approccio mentale orientato alla crescita (growth mindset), che permetta di vedere le attività sfidanti e ad alto rischio di fallimenti come un’opportunità unica di apprendimento e crescita.
Creare le condizioni per fallire meglio
I ragionamenti sugli errori e sugli apprendimenti si applicano innanzitutto a livello individuale, ma hanno anche implicazioni più ampie, a livello di organizzazioni e a livello di sistema.
A livello individuale, è emerso dagli studi condotti che le persone più resilienti ai fallimenti hanno le seguenti caratteristiche:
sono meno perfezioniste;
si liberano il più possibile di standard non realistici (io dovrei smetterla di seguire su Instagram solo modelli, ad esempio);
spiegano le sconfitte a sé stessi in modo equilibrato, senza esagerare e senza colpevolizzarsi.
Oltre alle dinamiche individuali, i libro di Edmondson si focalizza sugli errori che riguardano i gruppi di persone, soprattutto perché una parte consistente delle attività che ciascuno di noi svolge quotidianamente avviene all’interno di contesti organizzati (come le aziende per cui lavoriamo).
È possibile quindi promuovere un modo di lavorare che favorisca gli errori “intelligenti” e l’apprendimento? Secondo l’autrice sì, e lo si fa lavorando sulla “sicurezza psicologica” (“psychological safety”). La stessa Edmondson aveva definito come la sicurezza psicologica si generi sul posto di lavoro quando una persona ha la certezza di non essere punita o umiliata per aver dato voce a idee, domande, preoccupazioni o errori. Varie ricerche hanno dimostrato che le organizzazioni in cui è presente una maggiore sicurezza psicologica consentono alle persone di assumersi maggiori rischi interpersonali utili a far progredire e a raggiungere l’eccellenza. Inoltre, queste organizzazioni hanno anche migliori performance e tassi più bassi di burnout.
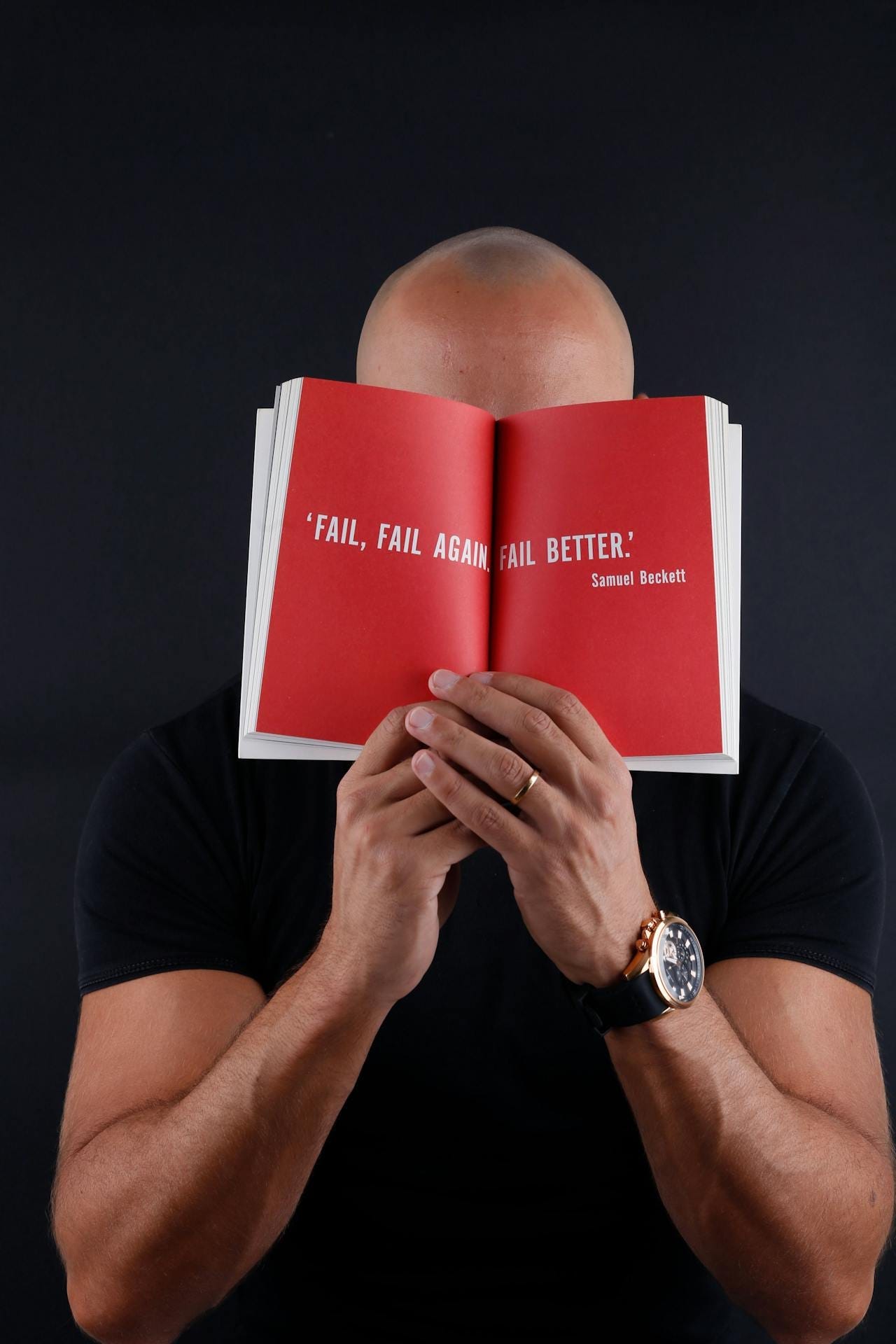
Un altro interessante concetto che viene collegato alla dimensione aziendale è quello delle HROs, ossia High Reliability Organization. Si tratta di organizzazioni nelle quali ci si sente sicuri di potersi affidare agli altri perché ciascuno è sempre pronto a individuare e correggere eventuali errori e deviazioni affinché le conseguenze peggiori siano evitate. Nelle HROs, dunque, le persone non sminuiscono i fallimenti, anzi. Ne sono osessionate perché li considerano il modo migliore per evolvere.
Allargando ancora di più lo sguardo, si riscontra come ci siano sempre maggiori “fallimenti complessi”, e questo succede perché il mondo in cui viviamo è altamente interdipendente e fa sì che sia difficile prevedere l’impatto e l’ampiezza delle conseguenze delle azioni dei singoli. L’aumento di interconnessione e complessità genera un potenziale maggior impatto anche per i fallimenti più piccoli.
È importante però focalizzarsi sui fallimenti di sistema (e non troppo sui fallimenti individuali) perché così facendo si riesce anche ad eliminare dall’equazione l’elemento della “colpa” che ricade sui singoli. Ci si può concentrare su come ridurre gli errori agendo sul sistema invece che punendo o sostituendo l’individuo.
Stop-Challenge-Choose: un framework per affrontare i fallimenti
In conclusione, l’autrice propone anche un possibile approccio da adottare sistematicamente per farsi trovare pronti nei momenti in cui si sbaglia: stop-challenge-choose.
Stop: si intende prendersi il tempo e lo spazio per non lasciarsi trascinare dalle emozioni che seguono un fallimento e cercare di indirizzarle nella giusta direzione. Fare un respiro profondo e riflettere su come le energie possano essere impiegate in positivo, cercando di focalizzarsi sul quadro più ampio e sul senso di quanto accaduto.
Challenge: significa iniziare ad approfondire, come passo successivo, i pensieri che sono scaturiti come conseguenza dell’errore commesso. Quanto sono utili? Quanto mi possono aiutare a raggiungere i miei obiettivi? È importante anche cercare di identificare interpretazioni alternative per rileggere l’errore da prospettive diverse.
Choose: si tratta infine di agire, dire o fare qualcosa che in risposta all’errore commesso consenta di avanzare verso l’obiettivo desiderato.
Sono questi solo alcuni dei concetti più interessanti che ho trovato all’interno di Right Kind of Wrong; se ti interessa acquistare e leggere questo libro, puoi farlo seguendo questo link (affiliato).
Gli approfondimenti del mese di Signor Ponza™️ è uno spinoff della newsletter I libri del mese di Signor Ponza.